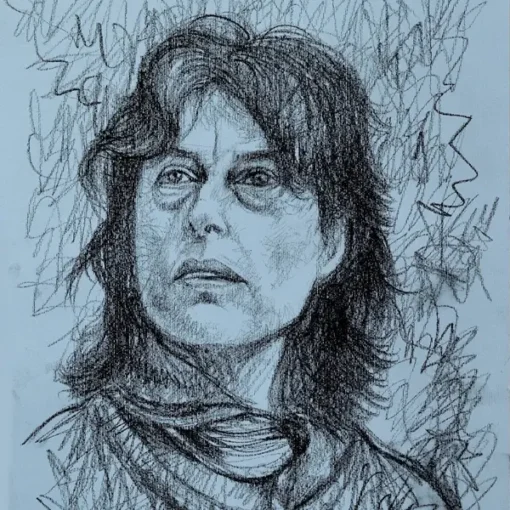Le bocchette riversavano sulla testa una lingua d’aria fredda dall’odore di formaldeide. Mi sistemai sul sedile di una fila vuota, quasi, mi raggomitolai formando una palla umana simile a uno di quei rotolacampo che infestano i deserti cinematografici del far west. Il vento li trascina per chilometri in una giostra ruotante che è insieme principio e commiato.
Il volo prese quota. Un’improvvisa spinta ascensionale mi ricacciò indietro e per un momento ebbi la sensazione di affondare nella carne di cui avvertii la stessa desolazione di quei paesaggi da poster appesi alle pareti delle agenzie di viaggio. Il pensiero che stavo lasciando nuovamente la mia città, e con essa l’insediamento di una vita intera ristretta ma pur sempre fatta di nascondigli, mi attraversò breve e spiazzante. Impiegai quell’intervallo a riordinare le voci che mi possedevano come anime in cerca di pace eterna, e io il medium seduta a un minuscolo tavolo pieghevole della classe turistica.
Quando lasciai Roma per la prima volta era Natale. Un giorno anestetizzato dalla stanchezza delle chiusure annuali, dalle scadenze, dalla corsa ai regali, da immancabili battibecchi in famiglia, da clacson intrappolati dietro un muro di auto in sosta vietata, dalle ore trascorse a friggere di cui rimane l’unto sui capelli. Sono partita durante un giorno di distratta indifferenza in cui persino il G.R.A non era lo stesso, volata via in lotta con un torto a cui la vita non mi ha preparata abbastanza. Perdere il lavoro ha lo stesso dolore di una menomazione, di una manomissione, di un’amputazione che ti lascia uguale a te stessa solo per metà, uguale agli altri ma diversa, come una bicicletta senza freni o una tazzina di caffè senza manico.
Ho guardato a Roma come si guarda a una malattia da cui curarsi, e a Bruxelles come alla ricompensata guarigione. Sentivo che quell’angolo a me straniero, straordinariamente ricco di meticciamenti, di intersecazioni umane, di nuovi scambi, di nuova umanità, poteva accogliere anche me e la mia risurrezione.
Non mi sono difesa da Bruxelles. L’ho accettata così diversa dalla mia città, educata e sommessa, che mai si agita ad alta voce, mai ti guarda negli occhi, o ti tocca per sentire di cosa sei fatta, dove il sole viene venduto in blister sotto forma di vitamina D, dove le relazioni sembrano più prodotti omeopatici che seguono il principio della similitudine alla realtà senza promettere la stessa durevolezza, dove si mangiano frutti di importazione dal Congo, come non fosse giunto ancora il momento di chiedere “posso?“.
A poco a poco, la città è apparsa più simile a una casa di cura con una grande sala d’attesa muta e sterilizzata alle percezioni. Mi è parso di essere entrata in una seconda zona di silenzio e di gelo imperturbabili, in cui la malattia romana incalzava lasciandomi una impotenza nuova addosso. I giorni si sono accesi e spenti senza far rumore, senza bucarsi, riavvolti l’uno sull’altro come un nastro di Möbius, ristretti che quasi ne ho toccato le superfici, ed è stato allora che ho capito che senza un lavoro è come non avere un corpo né un peso e un volume specifici né un nome né un sesso, un’identità, una cittadinanza da abitare, un inno da cantare.
E senza, è impossibile conquistare un luogo reale o fittizio, puntare verso un’uscita di sicurezza. Si scompare e basta. Con me cedevano le abitudini, la tv italiana, i sapori di casa, gli amici-colleghi, la femminilità fatta di curve e consensi, i tacchi, il trucco prima di uscire e mi invadeva un anonimato bianco e immobile come il cielo del Nord.
Avrei potuto vivere in Guadalupe, in Tibet, nel Sahara, non avrebbe fatto alcuna differenza, perché Bruxelles scavava un luogo-non-luogo che mi si agitava dentro. Ogni giorno, riscrivevo la mia biografia secondo impercettibili ammanchi che non mi rendevano mai la stessa, e le forme di uno stanziamento affettivo più si facevano anonime, più erano capaci di espandersi su un mappamondo irreale, su mille scelte da fare o rifare. Non ero più io né già qualcun’altra.
Poi, in mezzo a innumerevoli giornate frigide arrivavano germogli di vita.
Percepivo l’inconsistenza di un ottimismo che mi ridava una seconda partenza, l’illusione di una chiamata alla vita che reclutava proprio me, quando mi investivano i sorrisi calmi dei passanti ed estranei bonjour; quando i ragazzi del supermercato preparavano un pasto caldo a Julien, senza un tetto ma con il calore di un cane e di un libro sul marciapiede; quando Isabelle e molti non vedenti come lei attraversavano la città in metropolitana in un viaggio che qualcuno ha reso possibile come è giusto che sia; quando scoprivo che Bruxelles mi ha regalato un tempo per scrivere le parole che non credevo di avere, e uno per riscrivere la vita.
Chiusi la bocchetta dell’aria.
Di colpo, sapevo che la serenità può avere anche il sapore di arsenico, che da un dolore non si evade, e che no, non sarei più ritornata in un mondo sbagliato in cui ho creduto di essere pronta quando pronta non lo sono stata.
Atterro, mi fermo alla libreria dell’aeroporto: scelgo un libro per Julien.
Anche lui, un rotolacampo.
Paola Milicia
Immagine in evidenza: foto di Julia Volk – Pexels